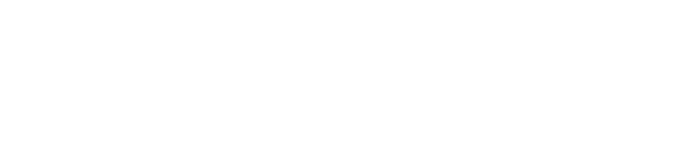Sull’ultimo numero di RTH (Research Trends in Humanities), rivista di pedagogia e di filosofia fortemente orientata all’interdisciplinarità, Daniele Demarco e Luisa Errichiello propongono un interessante articolo sullo smart working.
Non si tratta di una mera riflessione specialistica, né di una digressione generalista sul tema, ma di un acuto dialogo tra filosofia e management riguardo alle trasformazioni organizzative della nostra epoca.
Gli autori descrivono come l’informatizzazione del lavoro e, più in generale, delle pratiche sociali influisca sulla costruzione delle nostre identità frammentandole, talvolta, in un caleidoscopio di apparenze.
Si tratta di un fenomeno di vastissima portata che ha attratto in questi anni l’attenzione di molti specialisti impegnati a definire le sue possibili conseguenze sul vissuto personale e collettivo degli individui.
Partendo da un corpus di studi filosofici, sociologici e antropologici gli autori si sforzano di contestualizzare la loro indagine nell’ambito della ricerca organizzativa e manageriale.
I due ricercatori si riferiscono allo smart working come a un paradigma della condizione contemporanea in cui gli individui interagiscono a distanza affidandosi all’intermediazione dei dispositivi telematici.
Tali dispositivi, pur moltiplicando i contatti, sottraggono i soggetti alla socialità fisica e, così facendo, disperdono le nostre relazioni nell’ambito di una sfera totalmente incorporea.
Se, per un verso, ciò garantisce “sincronicità” e quasi “ubiquità” nei collegamenti (il che nell’ambito delle certe organizzazioni lavorative può soddisfare standard di efficienza e produttività), per un altro ci induce a ridiscutere i nostri ruoli, le nostre abitudini e le nostre funzioni. Un passaggio, quest’ultimo, non sempre agile e spesso legato un senso di dis-identificazione.
Secondo gli autori l’identità non è uno status ma un processo che include anche la relazione con gli altri soprattutto attraverso la condivisione di spazi che permettono di entrare anche in contatto fisico.
Con specifico riferimento alla condizione dei lavoratori questi spazi si identificano con una sede istituzionale (le fabbriche, gli uffici). Interagendo all’interno di questi luoghi, ogni individuo si espone a trecentosessanta gradi: attrae lo sguardo, catalizza l’attenzione, mobilita pulsioni e personalizza l’ambiente. Ed è anche in questo modo che egli definisce il suo carattere e la sua distinta identità professionale.
Naturale, dunque, che nelle condizioni di smart working, almeno per chi è abituato a lavorare in sede, la distanza fisica sia vissuta come un “esilio” che inibisce, innanzitutto, l’espressione di sé.
Una condizione resa ancor più paradossale dalla percezione di uno stato di controllo in remoto, in cui, pur sentendosi scrutato dall’organizzazione, il lavoratore non avverte il beneficio del riconoscimento.
È in questa condizione di assoluto paradosso che si può assistere a fenomeni ampiamente documentati. Sentendosi isolati dalle proprie organizzazioni e in qualche modo ridiscussi nella propria funzione, molti smart worker avvertono una sorta di ossessione di ribadire la propria identità professionale. Non potendo più farlo attraverso interazioni dirette e avendo a disposizione potenti strumenti informatici, essi tenderanno a rimanere sempre più connessi per impressionare e autorappresentarsi a distanza.
D’altronde il vivere in uno stato di “iperconnessione” offre l’opportunità di giocare con le proprie identità, scegliendo in maniera, per così dire, opportunistica quali aspetti esaltare e quali, mettere in ombra.
Molti lavoratori ricorrono alle tecnologie informatiche per comunicare selettivamente diverse immagini di sé: quella della persona disponibile e reattiva, quella della persona ricercata e riflessiva, quella della persona dilettevole e spassosa o, ancora, autorevole e impegnata.
In tutte queste circostanze l’impiego delle tecnologie non favorisce, però, una affermazione dell’identità, ma solo lo sdoganamento di un narcisismo di facciata che tradisce solitudine e bisogno di riconoscimento.
Infine, nel gioco a rialzo delle rappresentazioni social, ad essere penalizzato è il benessere lavorativo. Colti dalla tempesta delle sollecitazioni mediatiche e sentendosi, in qualche modo, obbligati a replicare, gli smart worker avvertono quella che in gergo tecnico è stata definita “workplace telepressure”, uno stato di stress che inibisce la concentrazione e comporta la perdita di produttività. In questo caso lo smart working, oltre a risultare nocivo per il singolo l’individuo, appare controproducente anche per l’organizzazione.
Nasce dunque la necessità di un approccio responsabile alla tecnologia, l’adozione di criteri di misura, sostenibilità e ragionevolezza in queste nuove modalità lavorative, che nella ricerca scientifica vengono indicati con i concetti di “connettività necessaria” e di “benessere digitale” o “digital wellbeing”.
Il primo, in particolare, evidenzia l’importanza di equilibrare la propria vita in rete al giusto mezzo tra due stati estremi: da un lato, uno stato in cui le potenzialità delle tecnologie non vengono adeguatamente sfruttate per ottenere una maggiore efficienza ed efficacia produttiva; dall’altro quello dell’“iper-connettività” e, cioè, un eccessivo e controproducente uso della tecnologia che si traduce in stress, burnout, disorientamento e disengagement.
Il concetto di benessere digitale, invece, indica una modalità di approccio alle tecnologie tesa a preservare il benessere dell’individuo, un’esperienza soggettiva in cui l’utilizzo delle tecnologie digitali garantisce una condizione di equilibrio ottimale tra i vantaggi e svantaggi della connettività. Benessere digitale, dunque, vuol dire riconoscere i vantaggi della connettività, minimizzando il rischio che il lavoratore perda il controllo della tecnologia o che la tecnologia comprometta il normale svolgimento delle sue attività.
Con specifico riferimento alla condizione degli smart worker, alla necessità di conservare un’identità e all’esigenza di rimanere produttivi senza compromettere l’equilibrio tra vita e lavoro, il conseguimento del digital wellbeing implica un’azione su tre livelli distinti.
Tale azione coinvolge sia gli stessi smart worker sia le organizzazioni a cui essi afferiscono, rendendo i primi responsabili per la propria condotta e le seconde responsabili di incoraggiare prassi sane.
Il primo livello d’azione riguarda la progettazione degli spazi di lavoro digitali, il secondo l’utilizzo degli strumenti tecnologici, il terzo le policy organizzative.
Riguardo al primo livello d’intervento, si pongono al centro le scelte di design degli spazi. A tal proposito è opportuno ricordare l’essenziale distinzione tra telelavoro e smart working. Quest’ultimo non è semplicemente lavoro da casa, ma può essere realizzato all’interno di vari ambienti pubblici e privati. Questi ambienti non dovrebbero presentarsi come meri supporti logistici di lavoratori privati di una sede istituzionale ma favorire sia la socialità fisica sia la costituzione di comunità virtuali in cui potersi esprimere e riconoscere.
La seconda leva di intervento attiene alla fruizione delle tecnologie. Al lavoratore dovrebbe esser sempre garantita la possibilità di adattare le funzionalità della tecnologia alle proprie esigenze, scegliendo – tra l’altro – se, quando e come connettersi.
Infine, con riferimento alla terza leva, le organizzazioni dovrebbero sostenere il processo di appropriazione delle tecnologie supportando lo smart worker con adeguate strategie. Al riguardo, accanto alle più note politiche di negoziazione della reperibilità lavorativa e al diritto alla disconnessione, diventa importante favorire una cultura organizzativa digitale che riconosca l’importanza del work-life balance e la supporti concretamente riducendo la pressione normativa che spinge il lavoratore ad una connettività ridondante.
Ciò può avvenire, ad esempio, motivando tutti i membri dell’organizzazione a fornire periodicamente dei feedback sulle competenze e le performance individuali.
L’affermazione di questa cultura può ridurre il vizio di una comunicazione eccessiva favorendo, al contempo, un riconoscimento dei meriti e delle identità professionali.
In questo senso, il feedback non viene percepito come critica intrusiva; ma come una preziosa occasione di ridiscussione di sé.
Contributo scritto dai ricercatori CNR-ISMed Daniele Demarco e Luisa Errichiello.
Per approfondimenti: Demarco D., Errichiello, L. (2021), “Smart working, stati di connettività e identità professionali in transizione Un dialogo critico tra filosofia e management”, Research Trends in Humanities – Education and Philosophy, vol.8, pp. 126-137.