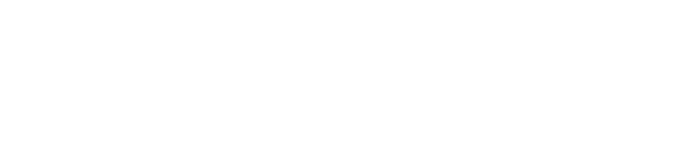Ciao Samuel, grazie per aver accettato di fare questa intervista. Ti chiedo se puoi presentarti e raccontare brevemente di cosa ti occupi.
Sono Samuel Lo Gioco e sono il fondatore di Smart Working Magazine, un editoriale che parla delle tematiche di smart working, e del Progetto Paisà Living, una start up nata da neanche un anno, rappresenta un network di destinazione per i lavoratori a distanza.
Guardando i tuoi profili social, ho letto che su linkedin ti descrivi come un “evangelista” dello smart working, che cosa intendi con questo termine?
Mi considero un evangelista perché effettivamente parlavo di smart working ancor prima della legge 81/2017, quando era un fenomeno che pochissimi conoscevano.
Il mio scopo, che poi dopo è anche diventato uno scopo comune del giornale, è quello di trasmettere la sana cultura del tema smart working perchè purtroppo tutt’oggi, pur avendolo vissuto tutti, compiamo un errore proprio di sintassi: per noi smart working è uguale al remote working, ma in realtà sono due cose distinte. È chiaro che il remote working è una delle attività interne allo smart working, ma lo smart working è un obiettivo molto più ampio che mette al centro le persone.
Studi dimostrano che quando le aziende non si limitano a considerare gli individui come semplici esecutori ma imparano a valorizzarli, ottengono miglioramenti nella performance, nell’engagement, nella fidelizzazione e in tutto ciò che c’è di collegato.
Quali possono essere secondo te i principali rischi dell’utilizzo dello smart working da parte di aziende e dipendenti?
Per le aziende va considerato lo scopo: considerare lo smart working in ottica di risparmio o per la paura di non attrarre talenti è un approccio sbagliato.
Bisognerebbe considerarlo adottando una prospettiva più ampia: focalizzarsi sui suoi effetti non nel breve termine, ma nel lungo termine. Adesso è molto difficile perchè la maggior parte dei progetti adottati sullo smart working sono progetti inside, sviluppati in casa senza considerare un punto di vista esterno; alcuni addirittura, applicando lo smart working nell’ottica di remote working: si aspettano un ROI – un ritorno – immediato, ma in realtà c’è da fare un lavoro culturale: ogni cultura ha bisogno di tempo e spesso le aziende non lo hanno.
Invece, le persone devono imparare a lavorare sul work life balance, perché il lavoro ormai ha invaso anche la nostra vita quotidiana.
Parliamo del suo progetto di Van working, grazie al quale hai girato i borghi Italiani a bordo di un van per incontrare le PA. Da cosa è nato e quale è il tuo obiettivo?
Il progetto Van working è nato proprio sotto la pandemia: parlando e svolgendo attività di cultura sul tema “smart working”, ho svolto tanta formazione a distanza soprattutto nella pubblica amministrazione.
Inoltre, ho svolto attività di mentorship a diverse piccole start up nate in quel periodo che volevano occuparsi di ripopolamento dei borghi in ottica smart working, con lo scopo di riportare i lavoratori nelle zone rurali.
Sono poi cascato in un articolo del “World Economic Forum”, secondo cui “entro 2025-26 in italia saranno riesumati ben 2000 borghi e resi siti idonei di lavoratori a distanza”.
Ora, io conoscendo in parte la pubblica amministrazione e le start up, mi sono accorto che mancava una figura che conoscesse bene il tema e il target e che riuscisse a visitare questi luoghi, con lo scopo di spiegare loro come concretamente possono diventare dei siti idonei di lavoratori a distanza.
Quindi, anche grazie a sostegni di sponsor e della Commissione Europea, ho realizzato questo progetto. Ho comprato un camper, e ho realizzato al suo interno un ufficio professionale. Per due anni ho visitato i borghi italiani con gli occhi di uno smart worker, incontrando la pubblica amministrazione. Questo mi ha permesso di avere con le istituzioni un confronto diretto sulle loro difficoltà e di aiutarle a trovare le soluzioni migliori per renderli siti idonei.
Adesso le propongo di lasciare questa breve intervista con un consiglio o un augurio ai giovani che si affacciano al mondo lavorativo.
“Non è facile dare consigli ai giovani quando si ha la barba bianca.
Sicuramente consiglierei loro di allenare la determinazione. Il periodo storico che stiamo vivendo non è a loro favore e spesso cercare opportunità all’estero è la strada più semplice.
D’altra parte, se vogliamo smettere di lamentarci delle cose che non funzionano e vogliamo impegnarci a farle funzionare, per quanto difficile dobbiamo restare.
Dobbiamo quindi imparare ad allenare la determinazione: anche quando tutto può sembrare difficile dobbiamo dimostrare maggiore impegno, anche con sacrifici, per andare a costruire qualcosa di nuovo.
I giovani determinati sono pochi, alcuni hanno anche vissuto all’estero e si sono resi conto che effettivamente l’Italia è il Paese più bello dove vivere e lavorare. Sono pochi, bisogna quindi cooperare, collaborare di più e impegnarci un po di più.
I giovani tendono a non sacrificarsi per il lavoro ma pensare di più alla vita; della serie: non viviamo per lavorare ma dobbiamo lavorare per vivere.
È vero che dobbiamo mettere sempre davanti la nostra vita, ma dobbiamo capire che se vogliamo fare la differenza ci devono anche essere sacrifici. Pensa a Zuckerberg che passava le notti in università a lavorare dietro a codici, Elon Mask che è sempre stato dietro alla programmazione. In realtà, nella storia, non c’è nessuno che è riuscito a fare la differenza nel mondo o nel suo piccolo paese senza sacrificio. Diventa tossico se resta per sempre, ma se è determinato in un periodo e spazio programmato e pianificato, allora sì.
Il motivo per il quale i giovani non si impegnano molto nel lavoro è che mancano le piccole gratificazioni, sono pochissime, ci vuole tanto tempo prima di riceverle e a volte non arrivano neanche. Questo è un aspetto che i manager devono imparare mentre i giovani imparano ad allenare la determinazione.