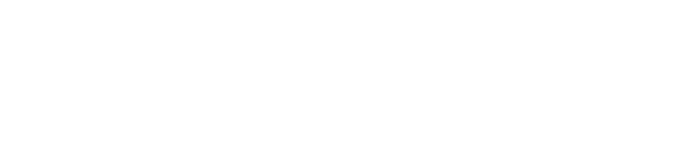It’s better to burnout than to fade away
Neil Young
Fino al 2010 per me il senso della parola “burnout” era quello contenuto in un verso della canzone di Neil Young, vergato a penna da Kurt Cobain nel suo biglietto d’addio nel 1994.
Poi quell’anno entrò in vigore il decreto attuativo sull’obbligo per gli imprenditori di valutazione del rischio stress – lavoro collegato in merito al Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. E lì quella parola tornò nel mio vocabolario – questa volta capendone appieno il significato che era oltre il “meglio bruciare subito che spengersi lentamente” del leader dei Nirvana – perché il burnout è un particolare fenomeno di stress definito per la prima volta nel 1974 da Herbert Fraudenberger. Per lo psicologo statunitense il “bruciarsi” era conseguenza di un prolungato stato di logoramento e esaurimento osservato negli operatori di comunità che avevano un rapporto diretto e continuativo con una fascia di utenza particolarmente disagiata.
Dagli anni ’80 il burnout è ormai entrato nella lista delle patologie da stress emotivo cronico nell’attività lavorativa, caratterizzato da: diminuzione della produttività, perdita di energia psico-fisica e spersonalizzazione dal proprio lavoro. A questo svuotamento emotivo si associa il senso di infelicità e fallimento.
Come mai ho tirato in ballo il burnout? Perché negli USA è considerato alla base di un fenomeno sociale che è iniziato la scorsa estate: il Big Quit.
The Big Quit
Da luglio, ovvero da quando negli USA è ricominciato il rientro in ufficio generale, si è assistito ad una serie di dimissioni di massa. In parte sono legate a mansioni a basso lavoro aggiunto, in parte sono state giustificate dagli economisti con il fatto che gli stipendi non hanno avuto gli aumenti attesi nella ripresa post pandemia. Ma sugli oltre 8 milioni di lavoratori americani che hanno rassegnato le dimissioni, i “colletti bianchi” sono una bella fetta.
In un mio precedente articolo su questo blog avevo scritto che Bloomberg News in estate riportava di numerosi lavoratori che avevano detto addio al vecchio lavoro una volta messi di fronte all’imperativo di tornare alla scrivania. Il sondaggio effettuato a maggio 2021 negli Stati Uniti, su un campione di 1.000 adulti, aveva rilevato che il 39% degli intervistati considerava il licenziamento se i capi non fossero stati flessibili sullo smart working. Evidentemente in molti hanno dato seguito al proposito! Tanto che su The Atlantic lo scorso 21 ottobre è uscito un articolo dal titolo “The Big Quit tells a bigger economic story” dove l’autrice Caroline Mimbs Nyce scrive:
<<The Great Resignation is more than just the sum of its quits. The pandemic is restructuring the economy, and forcing fundamental changes in the way that Americans think about work>>.
A quanto pare il fenomeno delle “grandi dimissioni” è stato osservato anche nel Regno Unito e in Germania. A cosa sia legato, dopo 18 mesi di pandemia è sospettabile.
Lo Smart Working può essere una risposta al malessere?
Gli osservatori in materia di workism indicano la pandemia come scatenante i fenomeni del burnout sia per le misure di contenimento per arginarla che -soprattutto – nel peggioramento delle condizioni lavorative. Inoltre, il SarsCoV2 ha stimolato nelle persone l’esigenza di passare più tempo con la famiglia e meno al lavoro.
Se negli USA, patria del lavoro assunto a identità sociale, viene meno la centralità dell’impiego come simbolo di salute dell’economia e base di tutti i parametri per misurarne il mojo (letteralmente è la “magia” nei riti voodoo, gli americani usano questo termine figurativo per indicarne lo slancio) significa che stiamo entrando in una nuova era.
Quella della ricerca della realizzazione personale senza passare necessariamente attraverso il lavoro e di un migliore work-life balance. Lo smart working sarà la cura a questo disagio? Con il progressivo miglioramento della situazione pandemica saremo testimoni di un ritorno alla normalità o una ristrutturazione dell’economia basata sul lavoro da remoto.