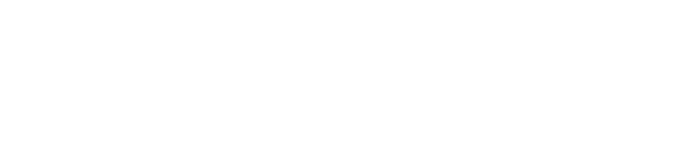Il burnout è un particolare fenomeno di stress definito per la prima volta nel 1974 da Herbert Fraudenberger. Per lo psicologo statunitense il “bruciarsi” era conseguenza di un prolungato stato di stress emotivo cronico e esaurimento osservato negli operatori di comunità che avevano un rapporto diretto e continuativo con una fascia di utenza particolarmente disagiata.
Dagli anni ’80 il burnout è entrato nella lista dei rischi correlati all’attività lavorativa, caratterizzato da: diminuzione della produttività, perdita di energia psico-fisica e spersonalizzazione. A questo svuotamento emotivo si associa il senso di infelicità e fallimento. Per capire il burnout, bisogna fare un passo indietro e coglierne le differenze con lo stress come da osservazione che ha fatto proprio su questo blog Vittoria Olivieri, in un articolo chiamato I cavalieri dell’Apocalisse di ogni lavoratore. Lo stress: “[…] non è una patologia, potrebbe diventarlo ma non è di per sé qualcosa di patologico. Nasce come reazione fisiologica dell’organismo ad una sollecitazione”. La condizione descritta da Vittoria è quindi uno stato individuale. Cosa succede se si riscontrasse diffusa in una fascia della popolazione, spesso quella che costituisce la generazione Z o i Millennials?
I would prefer not to.
Lo scrittore Herman Melville, già nel 1853 con il racconto Bartleby lo scrivano, aveva denunciato come la società moderna avesse una stortura organizzativa nel lavoro fonte di tracollo psicologico. Il protagonista del libro lavora presso uno studio legale di Wall Street e un giorno, dopo un periodo di attività intensissima, va appunto in burnout e si rifiuta di continuare la sua mansione pronunciando la celebre frase “I would prefer not to”.
170 anni dopo, oggi, il Global Workplace report di Gallup ha evidenziato che il 49% degli intervistati in Italia associa alla propria occupazione una percezione di stress. Abituati a questa condizione, Millennials e Generazione Z si trovano costrette a vivere situazioni tossiche croniche: privazione del tempo libero, precariato, bassi stipendi, iperconnessione digitale, in un circolo vizioso autoalimentante.
Sentirsi sempre esausti.
Davide Traglia su The Vision, in un articolo in cui denuncia la condizione del “sentirsi sempre esausti”, si scaglia contro la narrazione celebrativa del lavoro, che ha permesso da una parte l’asservimento totale al mito della produttività e dall’altra un approccio utilitaristico dell’istruzione piegata alla logica del mercato. Così “[…] ci sentiamo sempre più stanchi, sfibrati, e incapaci di ascoltare i nostri tempi interiori. Il meccanismo competitivo ci costringe a realizzare sempre maggiori prestazioni, a sfruttare noi stessi e gli altri fino alla consunzione fisica per vedere certificata socialmente la nostra identità”.
L’allarme che le persone siano il fusibile di questo sistema è dato dall’incremento dell’uso di farmaci – ansiolitici o antidepressivi diffusissimi pure nei giovani – e dal fenomeno delle Grandi Dimissioni. Il burnout a quanto pare non è una questione privata ma una condizione generazionale.